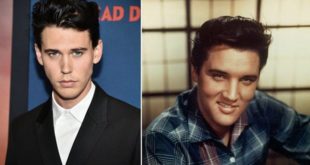The Get Down è ritmo, è musica, è una storia intensa e delicata, è uno scorcio di storia americana recente, è il racconto delle periferie, degli ultimi, è coinvolgente. The Get Down insomma è un esplosione di tutto quanto e rapisce lo spettatore e se, alla fine, non vi ritrovate a canticchiare Set Me Free, allora non lo avete veramente visto.

The Get Down, la componente musicale
Non si può certo negare che la componente musicale abbia un peso, pure notevole, nella storia, ma possiamo definire quest’opera un musical? Decisamente no.
La musica è parte integrante del racconto, ma in modo molto più naturale rispetto ad altre serie recenti andate in onda, come Roadies o Vinyl, peraltro abbastanza noiose. Qui la musica non è solamente un quadro di sottofondo o la definizione di un contesto o di un interesse, ma è qualcosa di più: è una speranza, un amore profondo che Luhrmann riesce a far percepire fisicamente allo spettatore, un qualcosa di vivo, che pulsa e che guida le persone. La colonna sonora è eccezionale, composta da brani originali e da classici riadattati, ha tutta quella freschezza che riesce a rendere lo spettatore/ascoltatore ancora più partecipe. La musica è sofferenza e sangue, ripicche e crudeltà, ma è la stessa musica ad essere l’unica a poter rappresentare la svolta di ognuno.
Luhrmann e la sua favola visionaria
In questa serie ritroviamo tutte le caratteristiche che contraddistinguono la poetica di Luhrmann: l’amore difficile, duro ma vissuto tutto d’un fiato, la bellezza che sgorga dal caos, l’arte che è un caleidoscopio di mille frammenti che ruotano velocemente su se stessi e si incastrano ogni volta a perfezione. 
Alcune scene sono da considerarsi iconiche per la qualità del montaggio e della sovrapposizione, come quando scorrono all’unisono e in parallelo sequenze ambientate in diversi contesti con diversi generi musicali e si incastrano senza stonare minimamente.
Luhrmann aggiunge anche una parte visiva che mischia riprese attuali e spezzoni d’epoca, interponendo saltuariamente anche sequenze girate oggi ma con stili di altri tempi. La stessa scena, la stessa inquadratura, finiscono a volte per declinarsi in molti modi e, anche qui, con assoluta lievità.
La storia di New York in The Get Down
La parte narrativa di The Get Down che racconta New York è, tutto sommato, un pretesto, per poter raccontare di un mondo dove le persone che lo abitano vivono senza speranza e come, da questo degrado, possano nascere invece arte e bellezza. 
Un ultima parola va detta per gli interpreti, che sono più funzionali al racconto che bravi. E sono bravi. Tutti, da Justice Smith a Herizen Guardiola, da Shamelik Moore a Giancarlo Esposito, fino a Jimmi Smits sono assolutamente in parte e riescono a dare anima e tridimensionalità al loro personaggio, tanto che è impossibile non stabilire empatia con loro, tutti ci siamo sentiti un po Ezekeil, un po’ Shaolin e le donne un po’ Mylene, però, la bellezza è proprio quella: per quanta bravura e versatilità (anche sul piano canoro) ci sia, è la storia a restare protagonista in toto, lasciando fluire i suoi attori, integrati alla perfezione con il racconto.
Per ogni notizia e aggiornamento sul mondo dello spettacolo, cinema, tv e libri, vi consigliamo di seguire la nostra pagina Facebook
 Intrattenimento.eu News e recensioni di cinema e serie tv
Intrattenimento.eu News e recensioni di cinema e serie tv